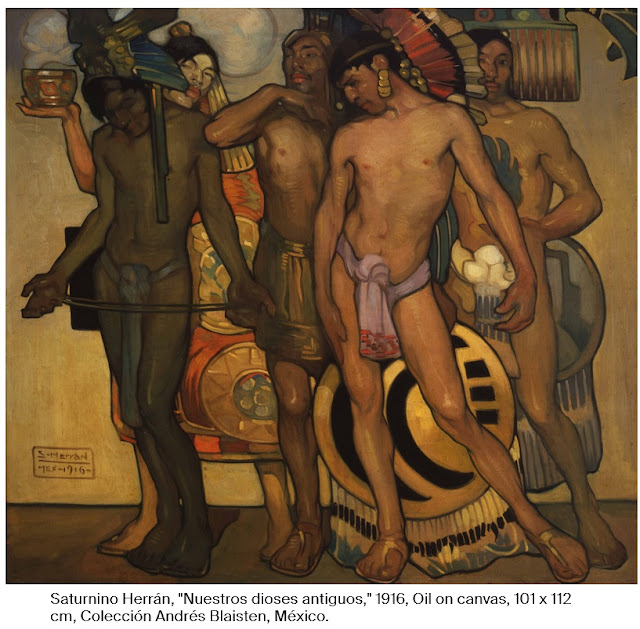La mostra è pensata dalla Fondazione Nicola Trussardi appositamente per gli spazi di Palazzo Morando, sede museale dedicata alla storia della città di Milano e residenza della Contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini (Alessandria d'Egitto, 1876 – Vedano al Lambro, Monza Brianza, 1945), che tra Otto e Novecento raccolse una vasta biblioteca su temi occultistici, spiritici e alchemici, oggi custoditi all’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana.
È a partire dalla figura della Contessa e da questo luogo carico di suggestioni che prende forma l’idea di un progetto espositivo unico, dedicato a pratiche artistiche ispirate all’invisibile, all’automazione psichica e alla trance come modalità di creazione.
Fata Morgana è un personaggio mitologico appartenente al ciclo delle leggende di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda, spesso associata a luoghi misteriosi come l'isola di Avalon, terra di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti: nell’immaginario collettivo è una maga potente – ora benevola, ora spietata, custode di segreti, illusioni e mondi intermedi, capace di potenti incantesimi, sortilegi e inganni – ma anche, nelle interpretazioni più recenti, una donna libera, indipendente e anticonformista che vive senza seguire le regole imposte dalla società.
La mostra trae ispirazione dal poema Fata Morgana, scritto da André Breton nel 1940, e intreccia storia, arte e misticismo in un viaggio attraverso visioni, estasi, apparizioni e immaginari alternativi per esplorare il rapporto tra arte, occulto e dimensioni interiori. Con dipinti, fotografie, documenti, disegni e oggetti rituali Fata Morgana: memorie dall’invisibile presenta le opere di medium, mistiche e mistici, visionarie e visionari, artiste e artisti che hanno aperto varchi tra il visibile e l’invisibile. La mostra indaga le contaminazioni tra arti visive e fenomeni paranormali, esoterismo, spiritismo, teosofia e pratiche simboliche, restituendo un panorama vibrante e frammentario di ricerche nate ai margini della storia ufficiale ma capaci di trasformare radicalmente le convenzioni dell’arte e della società.
Al centro della mostra ha un posto di rilievo un prezioso nucleo di opere di Hilma af Klint, leggendaria pittrice svedese che agli inizi del Novecento – guidata da presenze medianiche – sviluppò un linguaggio astratto del tutto originale, precorrendo pionieri dell’astrazione come Wassily Kandinsky e Piet Mondrian. Si tratta di una rara occasione per ammirare in Italia un corpus di 16 tele risalenti alla primissima fase di sperimentazione “automatica”: un’opportunità significativa, che si inserisce nel crescente interesse internazionale verso l’opera di af Klint, riscoperta dal grande pubblico a partire dal 2013 grazie alla Biennale di Venezia (curata da Massimiliano Gioni) e alla retrospettiva organizzata dal Moderna Museet di Stoccolma (allora diretto da Daniel Birnbaum, che è anche curatore del catalogo ragionato dell’artista), e che oggi è protagonista di un'importante mostra al MoMA di New York.
Accanto a quelle di Hilma af Klint verranno presentate opere e documenti di altre straordinarie figure storiche tra cui Georgiana Houghton, Emma Kunz, Linda Gazzera, Hélène Smith, Eusapia Palladino, Carol Rama, Man Ray, Pierre Klossowski, Victorien Sardou, Augustine Lesage, Annie Besant e Wilhelmine Assmann, che saranno poste in dialogo con artiste e artisti contemporanei che hanno interrogato gli stessi temi attraverso nuovi media e nuovi linguaggi come, tra gli altri, Judy Chicago, Kerstin Brätsch, Marianna Simnett, Andra Ursuţa, Diego Marcon e Chiara Fumai.
In mostra anche alcuni preziosi testi provenienti dalla biblioteca della Contessa Morando, concessi in prestito dalla Biblioteca Trivulziana.
Chiara Fumai, The Book of Evil Spirits, 2015 / single channel video, col., spund, 26'24” / video still / Courtesy Archivio Chiara Fumai
Fata Morgana: memorie dall’invisibile non si propone di confermare l’esistenza del soprannaturale, ma di raccontare come, in diversi momenti storici, pratiche considerate eccentriche abbiano scardinato convenzioni artistiche e sociali, mettendo in discussione gerarchie di genere, autorità scientifiche e limiti del pensiero razionale. In un’epoca segnata da nuove forme di ossessione e nevrosi, disinformazione e fascinazione per il mistero, la mostra riflette anche sulle relazioni pericolose tra tecnologia, spiritualità e potere.
Attraverso una rete di narrazioni visive – dai diagrammi per “macchine influenzanti” nate in contesti psichiatrici ottocenteschi, alle fotografie spiritiche, alle testimonianze di sedute medianiche – Fata Morgana compone un atlante dell’invisibile, un mosaico di mondi interiori, utopie, derive mentali e alternative radicali alla razionalità dominante.
“Con Fata Morgana la Fondazione Nicola Trussardi rinnova la propria vocazione a esplorare territori artistici inattesi e a dare spazio a narrazioni alternative, portando l’arte contemporanea oltre i confini tradizionali – dichiara Beatrice Trussardi, Presidente della Fondazione Nicola Trussardi –. Dopo progetti come La Grande Madre e La Terra Inquieta, ci confrontiamo oggi con il potere perturbante dell’invisibile: in un’epoca attraversata da nuove forme di spiritualità e di ricerca interiore, abbiamo scelto di indagare come ciò che sfugge alla vista continui a segnare profondamente la storia dell’arte e a interrogare il presente. Non è un caso che il poema Fata Morgana di André Breton sia stato scritto nel 1940: nei momenti più bui, il bisogno di immaginare un altrove e di riconnettersi a dimensioni invisibili si fa più urgente. Questo progetto nasce dall’incontro tra visioni radicali e sensibilità eccentriche, in un intreccio di arte, scienza e ignoto che interpreta pienamente la missione culturale della Fondazione.”
“Con Fata Morgana: memorie dall’invisibile Palazzo Morando si conferma non solo come un museo civico dedicato alla memoria storica della città, ma anche come un luogo capace di accogliere progetti espositivi visionari e sperimentali. Questa mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Nicola Trussardi e curata da un team di respiro internazionale, intreccia storia, arte e spiritualità, restituendo al pubblico un viaggio affascinante tra visibile e invisibile, tra immaginazione e ricerca interiore. È un esempio virtuoso di come la cultura possa aprire nuove prospettive, rileggendo il passato con occhi contemporanei e offrendo spazi di riflessione su temi oggi più che mai attuali, come l’identità, il mistero e la libertà espressiva", dichiara Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.
Con una selezione di oltre cinquanta figure tra intellettuali, artiste e artisti storici e contemporanei, la Fondazione Nicola Trussardi, attraverso Fata Morgana: memorie dall’invisibile, invita a ripensare il ruolo del margine, dell’inspiegabile e del visionario nella creazione artistica, affidando il progetto a un team curatoriale di grande esperienza internazionale, che vanta per la prima volta in Italia ben due ex Direttori della Biennale di Venezia, e facendo di Palazzo Morando un portale per accedere a dimensioni altre, sospese tra passato e presente, tra immaginazione e realtà.
Fata Morgana: memorie dall’invisibile
con opere e documenti di (lista in aggiornamento):
Hilma af Klint, Kenneth Anger, Giulia Andreani, Wilhelmine Assmann, Annie Besant, Kerstin Brätsch, André Breton, Marguerite Burnat-Provins, Marian Spore Bush, Milly Canavero, Guglielmo Castelli, Judy Chicago, Fleury-Joseph Crépin, Maya Deren, Fernand Desmoulin, Germaine Dulac, Minnie Evans, Madame Favre, Olga Frobe Kapteyn, Chiara Fumai, Linda Gazzera, Madge Gill, Anna Haskel, Hector Hyppolite, Gertrude Honzatko-Mediz, Georgiana Houghton, Anna Howitt, Victor Hugo, Corita Kent, Pierre Klossowski, Emma Kunz, Augustin Lesage, Goska Macuga, Diego Marcon, James Tilly Matthews, Henry Michaux, Lee Miller, Jacob Mohr, Sister Gertrude Morgan, Louise Nevelson, Eusapia Palladino, Stanisłava Popielska, Carol Rama, Man Ray, Victorien Sardou, Marianna Simnett, Hélène Smith, Lily Stockman, Rosemarie Trockel, Comte de Tromelin, Andra Ursuța, Johanna Natalie Wintsch, Adolf Wölfli, Anna Zemánkovà, Unica Zürn.
#FataMorgana
#FondazioneNicolaTrussardi
#PalazzoMorando